"Come mi accoglieranno i romani, cosa diranno di un Papa venuto da un Paese lontano?". Un attimo prima che i cerimonieri aprissero le ante della loggia della benedizione, la sera del 16 ottobre 1978, Karol Wojtyla, appena divenuto Giovanni Paolo II, pensava a come Roma avrebbe guardato a "un Pontefice straniero dopo i bellissimi e importanti Pontificati del Novecento". Questa rivelazione è del cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, per trentanove anni segretario particolare di Wojtyla.
"Mi confidò - racconta oggi il cardinale - la sua preoccupazione per Roma quando potei avvicinarlo, vincendo l'emozione di vederlo per la prima volta vestito di bianco. Mi disse anche che appena affacciato si era rassicurato perché nell'accoglienza della gente in piazza San Pietro aveva percepito un sentimento di speranza. Ecco, disse proprio così: ho sentito la speranza. Aggiunse che guardare la piazza dalla loggia gli aveva rafforzato la consapevolezza di essere Papa in quanto vescovo di Roma. Insomma, tra il Papa polacco e Roma era stato amore a prima vista. Ne era felicissimo e quando, negli anni, tornava col pensiero a quella sua preoccupazione iniziale lo faceva proprio per confidare di sentirsi più che mai "romano de Roma"".
Sono nitidi i ricordi di quel giorno di trent'anni fa in don Stanislao, come continua a essere chiamato, nonostante la porpora, quasi a mantenere quel legame con Wojtyla. "Al momento della fumata bianca - racconta - anch'io ero in piazza San Pietro, vicino al cancello della basilica. Quando il cardinale Pericle Felici pronunciò, in latino, il nome Carolum mi resi conto che stava per accadere l'impensabile. Poi disse: Wojtyla. Urlai di gioia prima di rimanere impietrito finché non sono stato accompagnato dal mio vescovo divenuto Papa".
Giovanni Paolo II lo vide appena rientrato dalla prima benedizione. Ricorda: "Gli dissi subito che la folla aveva accolto la sua elezione con gioia e io stesso avevo personalmente toccato con mano quella speranza che lui aveva avvertito. L'avevo vista nei volti, l'avevo ascoltata nelle parole delle persone accanto a me in piazza San Pietro. Sono testimone di come la sorpresa per la sua elezione - qualcuno pensò che il nuovo Papa fosse africano dopo aver sentito quel cognome difficile - si trasformò subito in speranza, forse per la carica di novità che portava con sé".
Don Stanislao racconta un altro episodio di quelle prime ore del Pontificato: "Con un sorriso complice e un po' del suo humour volle pure mettermi al corrente del primo strappo al protocollo. Prima di affacciarsi il maestro delle cerimonie, monsignor Virgilio Noè, si era raccomandato che il nuovo Papa impartisse la benedizione in latino senza fare discorsi. Giovanni Paolo II però non riuscì a trattenersi e incominciò a parlare in italiano. Un saluto rimasto storico: "Mi hanno chiamato da un Paese lontano... se mi sbaglio mi corrigerete". Nel raccontarmelo si mostrava certo di aver fatto bene a fare quel breve discorso, ma al tempo stesso sembrava quasi scusarsi con i suoi collaboratori per la prima di mille improvvisazioni".
L'elezione del primo Papa slavo, prosegue il cardinale, "era una novità da far tremare i polsi. Mentre iniziavo il mio nuovo servizio mi venne da pensare alle persone che a Cracovia pregavano perché non fosse eletto, in tanti non volevano che lasciasse l'arcidiocesi. E mi ricordai anche del funzionario polacco che, prima della partenza per il conclave, aveva tolto al cardinale Wojtyla il passaporto diplomatico, rilasciandogli solo quello turistico, con la minaccia che i conti li avrebbero fatti al ritorno in patria. La sera del 16 ottobre non rimasi in Vaticano, tornai ai Collegio polacco. Non chiusi occhio. Per tutta la notte restai attaccato alla radio per carpire notizie su come l'elezione del cardinale di Cracovia era stata accolta, soprattutto in Polonia. Mi resi conto che la Chiesa del silenzio cominciava a parlare con la bocca del Papa".
Come Giovanni Paolo II visse i momenti dopo la prima benedizione? "Non si fece prendere da frenesie. Volle cenare con i cardinali, poi si ritirò nella stanza che gli era stata assegnata per il conclave, nel mezzanino dell'appartamento del segretario di Stato. La condivideva con il cardinale Corrado Ursi. Si mise a scrivere di suo pugno, in latino, il discorso programmatico per la messa dell'indomani. E cominciò a pensare all'omelia della celebrazione per l'inizio del ministero petrino". È il discorso rimasto famoso per il motto, linea-guida del Pontificato: "Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo". Spiega don Stanislao che "queste parole le aveva maturate negli anni. Erano espressione della sua fede. Le ha vissute, pregate. Mi disse che le considerava adatte per scuotere le coscienze e iniziare la sua nuova missione di proclamare il Vangelo al mondo intero. Sono testimone che ha scritto quell'omelia da solo. Conservo il testo autografo".
Il Papa era consapevole che quelle sue parole avrebbero avuto un effetto dirompente soprattutto laddove la libertà era negata? "Sapeva molto bene - è la convinzione di don Stanislao - che le dittature si reggono solo sulla paura. Per abbattere quei regimi non disponeva di forze armate. Il Papa non ha divisioni, come ironicamente diceva Stalin. Ma ha la parola. Il suo obiettivo era chiaro: indicare la verità di Cristo per infondere nella gente un senso di libertà interiore. È questo stimolo alla libertà che ha dato ai popoli la forza di cambiare, di lottare contro i sistemi repressivi, politici ed economici. Quell'invito a non aver paura ha innescato una rivoluzione straordinaria, senza spargimento di sangue. Ha contribuito a far crollare i muri e ha messo in discussione la logica della guerra fredda, voluta dalle grandi potenze nucleari". Tutto questo, però, non faceva parte di una strategia politica. Liberare la gente dalla paura è stata, fin dal primo giorno, la forza e la novità del suo Pontificato: "Non si tratta di ideologia ma di Vangelo. Voleva che la Chiesa fosse là dove è l'uomo".
Il segreto di Wojtyla è stato senz'altro quello di aver mostrato il volto umano di Dio. Ne è certo don Stanislao: "La mia esperienza mi dice che la gente non cercava tanto lui, ma la persona di Dio di cui era testimone. E rivelo un altro segreto: non si può comprendere Giovanni Paolo II escludendo la preghiera e il suo rapporto con la Parola. In questo non c'era nulla di bigotto. Anzi, niente in lui pareva essere più naturale. Neppure il giorno dell'elezione venne meno a questo stile". E aggiunge: "Non si dava mai pace per cercare sempre parole e modi nuovi per annunciare Cristo. Così quando mandava all'aria il protocollo non era alla ricerca di popolarità ma di un sistema per testimoniare l'amore di Dio". C'è un gesto che, nelle parole del segretario, esprime l'irruenza spirituale di Giovanni Paolo II: lo scendere sulla piazza, alla fine della messa del 22 ottobre 1978, in mezzo ai disabili e alzare il pastorale muovendolo come fosse una bandiera.
Per don Stanislao, in questi giorni, c'è stato un altro anniversario da ricordare: l'8 ottobre 1966 l'arcivescovo Wojtyla gli propose di diventare suo segretario. "Quando devo iniziare?" chiese. "Subito" fu la risposta. Oggi commenta: "Quel giorno imparai a stargli vicino. L'ho fatto per trentanove anni, prima a Cracovia poi a Roma. Ho visto la mia veste macchiata del suo sangue, il 13 maggio 1981. E ho ripensato ai versi che scrisse per san Stanislao patrono di Polonia: se la parola non ha convertito sarà il sangue a convertire. Sempre sono rimasto accanto a Karol Wojtyla. Io, sacerdote accarezzato da un dono e da un mistero".
(©L'Osservatore Romano - 16 ottobre 2008)

 Non ho mai condiviso le critiche laiciste al fatto che Papa Wojtyla abbia sempre riproposto senza compromessi verità per lui indiscutibili, su questioni (una ne nomino fra tante) come l'aborto. Anche nel più aperto degli incontri fra i credenti di fedi diverse, compresa la mia fede laica, ciascuno ha, secondo coscienza, il diritto e dovere dell'annuncio della propria verità, nel momento stesso in cui, attraverso il dialogo, s'impegna seriamente all'ascolto della verità altrui, e rinuncia a imporgli la propria. Nel dialogo, quello che dice l'altro dovrebbe essere ancor più importante di quello che dici tu stesso: e la fede sincera dell'altro, misteriosamente, non indebolisce, ma rafforza la tua.
Non ho mai condiviso le critiche laiciste al fatto che Papa Wojtyla abbia sempre riproposto senza compromessi verità per lui indiscutibili, su questioni (una ne nomino fra tante) come l'aborto. Anche nel più aperto degli incontri fra i credenti di fedi diverse, compresa la mia fede laica, ciascuno ha, secondo coscienza, il diritto e dovere dell'annuncio della propria verità, nel momento stesso in cui, attraverso il dialogo, s'impegna seriamente all'ascolto della verità altrui, e rinuncia a imporgli la propria. Nel dialogo, quello che dice l'altro dovrebbe essere ancor più importante di quello che dici tu stesso: e la fede sincera dell'altro, misteriosamente, non indebolisce, ma rafforza la tua.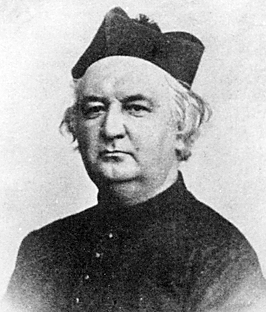 Per fortuna nell'esplosione non ci sono stati morti o feriti, ma solo danni materiali. Subito dopo l'attentato alcuni giovani volontari si sono prodigati a richiudere la porta danneggiata dall'ordigno.
Per fortuna nell'esplosione non ci sono stati morti o feriti, ma solo danni materiali. Subito dopo l'attentato alcuni giovani volontari si sono prodigati a richiudere la porta danneggiata dall'ordigno. "È importante che ogni confessore senta" la responsabilità di invitare il penitente alla lettura delle Sacre Scritture "e si assuma questo impegno. Forse il Sinodo potrebbe rivolgere un invito specifico a questo riguardo". Lo ha auspicato il cardinale Tarcisio Bertone aprendo la serie dei quindici interventi liberi con cui sabato pomeriggio, 11 ottobre, si è chiusa la prima settimana dei lavori sinodali.
"È importante che ogni confessore senta" la responsabilità di invitare il penitente alla lettura delle Sacre Scritture "e si assuma questo impegno. Forse il Sinodo potrebbe rivolgere un invito specifico a questo riguardo". Lo ha auspicato il cardinale Tarcisio Bertone aprendo la serie dei quindici interventi liberi con cui sabato pomeriggio, 11 ottobre, si è chiusa la prima settimana dei lavori sinodali. "Come un martello frantumando la roccia sprigiona molte scintille, così anche un solo passo delle Scritture dà luogo a diversi significati per cui ogni versetto si apre a molteplici letture". Questa suggestiva dichiarazione del trattato talmudico sul Sinedrio (34 e 35) risuona ripetutamente e secondo iridescenze diverse nella tradizione giudaica: "La Bibbia ha settanta volti (...) In ogni parola sacra brillano molte luci (...) Dio ha pronunciato una parola, due ne ho ascoltate". Né era stata da meno la tradizione patristica che con san Gregorio Magno nelle sue Omelie su Ezechiele ripeteva che "le parole della Sacra Scrittura sono pietre squadrate" (ii, 9, 8), le cui facce differenti rivelano diversi profili, un po' come dirà, secoli dopo, Gandhi a proposito della verità: "Essa è simile al diamante: è una sola, ma ha molte facce".
"Come un martello frantumando la roccia sprigiona molte scintille, così anche un solo passo delle Scritture dà luogo a diversi significati per cui ogni versetto si apre a molteplici letture". Questa suggestiva dichiarazione del trattato talmudico sul Sinedrio (34 e 35) risuona ripetutamente e secondo iridescenze diverse nella tradizione giudaica: "La Bibbia ha settanta volti (...) In ogni parola sacra brillano molte luci (...) Dio ha pronunciato una parola, due ne ho ascoltate". Né era stata da meno la tradizione patristica che con san Gregorio Magno nelle sue Omelie su Ezechiele ripeteva che "le parole della Sacra Scrittura sono pietre squadrate" (ii, 9, 8), le cui facce differenti rivelano diversi profili, un po' come dirà, secoli dopo, Gandhi a proposito della verità: "Essa è simile al diamante: è una sola, ma ha molte facce". Terza e celebrata analisi è quella "psicologico-psicanalitica" che, a partire da Freud e Jung, ha occupato un posto sempre più rilevante nella cultura contemporanea e che, perciò, è stata applicata anche alla religione e ai testi sacri. In particolare, oltre alla comprensione delle dinamiche proprie della conoscenza e coscienza religiosa, questo approccio ha favorito l'approfondimento dell'uso e del significato del simbolo che è la via regale della comunicazione religiosa. Molti sono stati i risultati positivi ottenuti anche per la penetrazione dell'esperienza di Gesù e della Chiesa così come è presentata dai Vangeli. Facile è intuire anche le degenerazioni riduttive. Il caso del tedesco Eugen Drewermann, sul quale è stato detto e scritto molto, è emblematico: le sue interpretazioni secondo gli archetipi junghiani di Marco (1987-88) e Luca (1986) e la sua Psicologia del profondo ed esegesi (1984) sembrano dissolvere la dimensione storica dell'annunzio cristiano riducendolo a pura interiorità psicologica.
Terza e celebrata analisi è quella "psicologico-psicanalitica" che, a partire da Freud e Jung, ha occupato un posto sempre più rilevante nella cultura contemporanea e che, perciò, è stata applicata anche alla religione e ai testi sacri. In particolare, oltre alla comprensione delle dinamiche proprie della conoscenza e coscienza religiosa, questo approccio ha favorito l'approfondimento dell'uso e del significato del simbolo che è la via regale della comunicazione religiosa. Molti sono stati i risultati positivi ottenuti anche per la penetrazione dell'esperienza di Gesù e della Chiesa così come è presentata dai Vangeli. Facile è intuire anche le degenerazioni riduttive. Il caso del tedesco Eugen Drewermann, sul quale è stato detto e scritto molto, è emblematico: le sue interpretazioni secondo gli archetipi junghiani di Marco (1987-88) e Luca (1986) e la sua Psicologia del profondo ed esegesi (1984) sembrano dissolvere la dimensione storica dell'annunzio cristiano riducendolo a pura interiorità psicologica.